Il gallo di Socrate
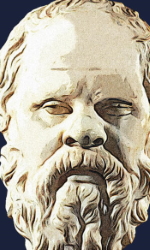
Un gallo ad Esculapio : Vita e morte di Socrate / Alfio Siracusano. - Carlentini : Due tre due di Salvatore Arcidiacono, 2021. - 243 p., [3] : br. ; 21 cm. - (Contorni). - ISBN 978-88-99573-43-0.
"Questo non è il libro di un filosofo, e neanche di uno storico o di uno psicanalista. Intendo di uno storico o di un filosofo o di uno psicanalista di professione. È solo una, l’ennesima riflessione sulla figura di Socrate da parte di chi ne ha sempre ammirato la coerenza morale" mette le mani avanti Alfio Siracusano nella premessa al suo "Un gallo ad Esculapio : Vita e morte di Socrate". Quella di Siracusano è una scommessa, riuscire a parlare di Socrate sottraendo - sia lo scrittore che il lettore - alle complicazioni settoriali; ed è una scommessa vincente: questo libro è un buon esempio di divulgazione, anche perché il suo autore ha letto ed è aggiornato su quanto si è scritto nella letteratura recente riguardo a Socrate (Luciano Canfora ecc_). Scritto con linguaggio piano e chiaro e dunque consigliabile a un pubblico vasto di lettori.
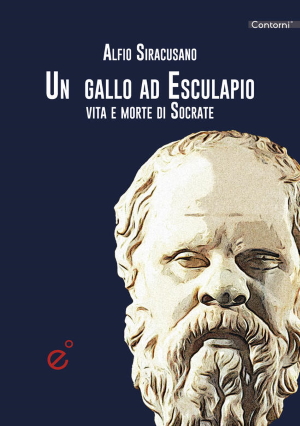
- Siracusano - Copertina del libro Un gallo ad Esculapio
Il testo ricostruisce la vita di Socrate e le vicende politiche ateniese intrecciate ai "tempi" di Socrate. Mi sembrano almeno due le pregevoli particolarità qui da rilevare: in due punti l’autore interviene con sue traduzioni ai testi tramandatici: l’ampia "Apologia" di Socrate finale, cioè l’autodifesa che Socrate fece al processo cui fu sottoposto e che ci viene tramandata da Platone (che di Socrate fu giovane seguace). E lo scambio, ripreso da Tucidide, tra gli ambasciatori dei Melii e quella degli Ateniesi (pp. 120-127). Per quest’ultima parte, Siracusano fa un’operazione particolare: fa una parafrasi, cioè prende il brano originale e lo "attualizza". Ed ecco che i Melii sono gli irakeni protagonisti della guerra del 2003-2011 in Medio Oriente, e gli Ateniesi sono gli Stati Uniti e le democrazie occidentali. Il cambio di casacca e lo spostamento temporale, lo slittamento di senso, non è peregrino. Qui si entra nel senso stesso di questo libro, e nella sua intima necessità ontologica.
Perché a noi dovrebbe interessare occuparsi o parlare di questo ometto (non particolarmente bello, tra l’altro, a quanto dicono le fonti) vissuto 2400 anni prima di noi? in maniera indiretta, credo, Siracusano ha una sua risposta: perché l’Atene "al tempo di" Socrate pone a noi uomini e donne d’oggi, problemi "cogenti" (come si dice), attuali. Il libro non è un caso che sia dedicato "alla mia città". E il "problema" è proprio la città, la comunità in cui si vive, e le leggi e le decisioni che la propria città prende e che coinvolgono la vita di tutti i suoi membri, chiamano alla diretta responsabilità tutti coloro che ne sono parte, e - nel caso di Socrate, ma non solo - decidono sulla vita e la morte dei suoi componenti.
Attraverso le vicende contestuali, politiche e militari che coinvolgono Atene negli anni di Socrate (dunque tra il -450, stante l’attestazione attribuita della nascita di Socrate al -470/-469, e il -399 anno attribuito della morte di Socrate) la domanda converge su cosa è in realtà la democrazia, e come una democrazia si debba comportare nella realtà: cos’era la "democrazia" ateniese in quegli anni e cosa è la "democrazia" nel nostro tempo?
Attraverso le vicende del processo e la condanna finale di Socrate, dunque attraverso una vicenda personale, individuale, la posizione dell’individuo nei confronti della collettività (della "città"): il punto esistenziale e politico. Anche, il problema dell’intellettuale e la sua posizione, ancora una volta esistenziale e politica, rispetto alla comunità in cui vive e al proprio "tempo".
Ps: Il titolo del libro fa riferimento all’ultima "volontà" di Socrate, come ci è stata tramandata. Prima di esalare l’ultimo respiro dopo aver bevuto la cicuta, Socrate ricorda all’allievo di sacrificare un gallo a Esculapio. Come per molte "ultime parole" delle figure esemplari del passato (da Socrate a Gesù) i posteri nel tempo hanno discusso. Si è detto come l’usanza di sacrificare il gallo a Esculapio era per i greci dell’epoca un ringraziamento per essere guariti da una malattia. Nietzsche intervenne (perfidamente) per dire: la morte (la parte finale del dialogo di Socrate con gli amici affronta il problema della morte, dell’aldilà ecc_) è una liberazione e la vita è una malattia, Socrate allude a questo. Qui lasciamo ai lettori perseguire l’interpretazione più congeniale.
- Ci sono 0 contributi al forum. - Policy sui Forum -