Nino, campione di "campo e sfida"
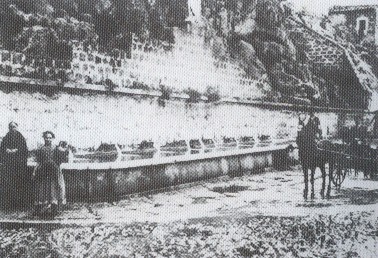
Quindicenni, un giorno mi parlò di un libro e dei suoi aspetti pruriginosi, “Gli indifferenti” di Alberto Moravia. Me lo prestò e mi ci buttai a capofitto.
di
Antonio Carollo
- mercoledì 21 maggio 2008
- 3931 letture
“Campo e sfida” è un vecchio gioco di squadra per bambini grandicelli (9-13 anni circa) e tosti basato su velocità, capacità di accelerazione e di scatto, tempestività, abilità di manovra e di esecuzione. Si praticava a Trabia negli anni Quaranta. Luogo deputato per eccellenza era il Palco della Favara (piazza Lanza) in quanto perfetto per lunghezza, larghezza e comodità di appoggi, per via delle funzionali balaustre che lo delimitavano. Adesso questo manufatto è un po’ ridimensionato. Le partite si svolgevano mezz’ora prima dell’entrata a scuola e spesso di pomeriggio, se si riusciva a mettere insieme il prescritto numero di giocatori. Regola principale del gioco: chi dalla linea, diciamo, di meta si proiettava in campo dopo l’avversario aveva il vantaggio di poterlo affrontare in dribbling offensivo e di inseguirlo per toccarlo e farlo prigioniero. Si tirava a sorte tra le due squadre per scegliere il campo o la sfida. Agli sfidanti spettava la prima mossa. La squadra a cui toccava il campo lo doveva difendere dalle incursioni degli avversari e, se possibile, contrattaccare. La vittoria si conseguiva con l’attraversamento della linea di meta avversaria o prendendo prigionieri tutti i giocatori della squadra competitrice. La difesa consisteva nell’intercettazione degli avversari a mezzo di contatto fisico. I prigionieri doveva attaccarsi alla balaustra, stare fermi facendo una catena con le mani e attendere di essere liberati. I prigionieri di una squadra stavano alla balaustra posta alla sua destra, sul tratto più vicino; quelli dell’altra analogamente alla balaustra di fronte. La partita iniziava con l’attacco di uno sfidate che non poteva fare altro che stuzzicare gli avversari in quanto in quel momento la linea di fondo era difesa dall’intera squadra, 5 o 7 membri, ben decisi a vendere a caro prezzo la propria pelle. Attraversata la metà campo di solito gli andava contro un avversario, che gli si avvicinava per piazzare al momento giusto il suo scatto, toccarlo e farlo prigioniero. Se il primo giocatore era abbastanza veloce e sapeva rispondere allo scatto sfuggendo al contatto zigzagando, poteva attirare il contendente nella propria metà campo ed esporlo alla zampata di un suo compagno. In questa lotta tra inseguitore e inseguito, in caso di pericolo per il primo, interveniva un secondo difensore per affrontare il secondo sfidante. Se il primo difensore non riusciva a toccare il suo avversario, si sottraeva al pericolo di cadere prigioniero rientrando alla propria linea di meta e ricostituendo così la forza d’urto della squadra per gli ulteriori attacchi. A questo punto poteva intervenire il terzo sfidante in difesa del secondo e poi viceversa, il terzo difensore contro il terzo sfidante. Ad un certo punto attacchi e rientri si susseguivano. L’inseguitore poteva insistere non dando scampo alla sua preda ma doveva guardarsi bene dagli avversari sopravvenienti. I dribbling spesso miravano a spiazzare l’avversario per fiondarsi sui propri compagni prigionieri, toccarli e liberarli. E così via. Nella lotta fatta di inseguimenti e di scontri nel rispetto della regola, ripeto, del vantaggio di chi si faceva sotto per ultimo, poteva accadere che una squadra si ritrovasse decimata e alla mercé dell’altra. In tal caso venivano fatti prigionieri gli ultimi avversari o si violava la linea di meta. L’asprezza della lotta si misurava sia nella fase di cattura degli avversari che in quella della liberazione dei compagni prigionieri.
Francamente non conosco l’origine di questo gioco. La sua connotazione,un po’ guerresca, mi fa pensare a qualche connessione col mondo dei militari, anche perché si stava uscendo dalla guerra e via via si entrava in un duro dopoguerra. L’avranno portato le truppe americane?
Col compagno di scuola Nino Di Vittorio mi misuravo tutti i giorni a “campo e sfida”. Aveva un fisico non appariscente, ma robusto e muscoloso. Era veloce e scattante, la bestia nera degli avversari; la sua presenza in campo uno spettacolo. Imprendibile in fase difensiva, incontrastabile in quella offensiva. I suoi dribbling ubriacavano chi gli stava di fronte. Inutile inseguirlo o catturarlo; lui schizzava e vanificava ogni tentativo di bloccaggio. Nel medesimo tempo era l’angelo vendicatore dei suoi compagni in prigione: un guizzo ed erano liberi. Così ricomponeva continuamente il potenziale della sua squadra che si riproponeva contro gli avversari con forze sempre rinnovate: un muro per gli avversari. Io militavo per forza nella squadra competitrice. Ero l’unico che s’avvicinava alla sua velocità e alla sua grinta, ma non ai lampi dei suoi scatti. Impossibile giocare insieme: non ci sarebbe stata partita per gli altri contendenti. Forse per questo, fuorché in campo, eravamo amici inseparabili. Il teatro dei nostri giochi e delle nostre scorrerie erano le vie intorno allo stratuneddu, via Vaianisi, via Tusano, il piazzale della Chiesa, la scalinata. Con me parlava volentieri; ci divertivamo molto. Ho imparato qualcosa da lui. Era osservatore e intelligente, più avanti degli altri nello sviluppo intellettivo. Dopo le elementari io mi preparai con la maestra Dentici, moglie del maestro Gattuccio, brusca ma bonaria come il marito, e feci gli esami di ammissione al ginnasio. Non fummo più compagni di scuola; credo si sia indirizzato alla Scuola di avviamento, ma trascorrevamo lo stesso molto tempo insieme. Da adolescenti facevamo i nostri strusci in Corso La Masa facendo accanite discussioni e buttando le prime occhiate sulle ragazzine a passeggio (allora si poteva, non c’erano le auto). Eravamo bravi anche a ’bazzica’, al bigliardo, e a ping pong. A lui devo una scoperta importante per me: la letteratura del Novecento. Quindicenni, un giorno mi parlò di un libro e dei suoi aspetti pruriginosi, “Gli indifferenti” di Alberto Moravia. Me lo prestò e mi ci buttai a capofitto. L’intrico di rapporti sessuali e di bassi interessi di una media borghesia meschina e grossolana ci fece aprire la mente sul sesso e sul mondo degli adulti. Ci passammo altri libri. Leggemmo anche “Ossi di seppia”di Eugenio Montale, sforzandoci di capirci qualcosa. Un’enorme impressione ci fece “Un uomo finito” di Giovanni Papini, in cui è tracciato in modo cupo ed esasperato l’itinerario intellettuale dell’autore, la sua ribellione e il desiderio folle di affermazione dell’io. Bazzicavamo un po’ al tabacchino d’angolo della strada della scalinata e della via principale del centro di Termini alta dove erano esposti tanti bei libri tra cui spiccavano quelli della collezione BMM della Mondatori. con copertina rigida, giallina e riquadro dorato in alto col nome dell’autore e titolo, sopraccoperta dello stesso colore con riquadro rosso, caratteri in bianco e risvolti. Poi cominciammo a frequentare il Supercinema di Termini. Una o due volte la settimana, quando avevamo qualche centinaio di lire in tasca, montavamo sull’autobus e scendevamo a Termini bassa dove avevano costruito questo cinema da sogno. Le file di poltroncine tappezzate, in leggera pendenza, le pareti e il soffitto illuminati a luce diffusa, lo schermo laggiù, immenso, le maschere in livrea, ci trasportavano in un altro mondo. I film erano tutti di prima visione e di qualità. In quel cinema abbiamo visto tanti film americani ma anche i capolavori della commedia all’italiana. I film di Fellini ci facevano venire i brividi. Film, registi, attori erano divenuti pane quotidiano dei nostri discorsi. Un pomeriggio abbiamo avuto una sorpresa: nell’ultima fila di poltrone erano seduti, uno accanto all’altra, Gian Maria Volonté e Carla Gravina. Si sbaciucchiavano beatamente. Ce ne siamo accorti nell’intervallo a luci accese. Dei vicini di posto bisbigliavano che stavano girando un film nei dintorni di Termini e a Cefalù. A noi non ci sembrava vero. Due dei nostri divi più amati si trovavano a due passi da noi in carne ed ossa! Incredibile! Ci guardavano stupiti del nostro stupore. Poi accennarono ad un saluto con la mano. Queste consuetudini proseguirono per anni. Poi io partii per lavoro. Egli s’impiegò all’Ospedale dei bambini di Palermo. Ci rivedevamo di tanto in tanto ai miei rientri in paese. Notavo la sua totale dedizione alla famiglia.
- Ci sono 0 contributi al forum. - Policy sui Forum -