Epepe, di Ferenc Karinthy

Epepe / di Ferenc Karinthy. - Milano : Adelphi, 1970 (Fabula, 2015)(Gli Adelphi, 2017)
Epepe, arrivato nelle nostre librerie alla fine del 2015, rappresenta uno degli ormai vari casi di opere letterarie dell’Europa dell’est rimaste per lunghi anni senza circolazione in occidente, soffocate dalla cortina di ferro, che ha rallentato i rapporti culturali fra le due Europe ben oltre la caduta dei muri. L’autore Ferenc Karinthy, morto nel 1992 a settantun’anni, è ungherese, al pari di Sándor Márai e di Magda Szabó, che pure abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare tardivamente. La sua produzione comprende una dozzina di romanzi, dal primo del 1943, il cui titolo potrebbe suonare nella nostra lingua Notte di don Giovanni, ma per ora dobbiamo accontentarci di Epepe del 1970, l’unico arrivato in occidente, a partire dall’edizione inglese del 2008.
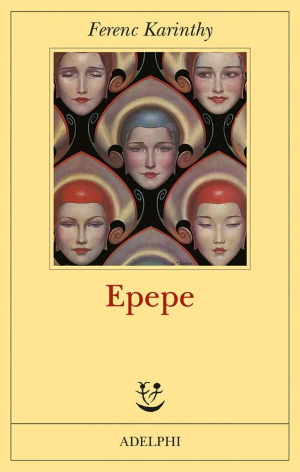
- Epepe, di Ferenc Karinthy
Epepe colloca Karinthy fra gli eredi di Kafka: eredi, non imitatori, perché gli sono proprie l’originalità inventiva, la qualità del monstrum da cui è inghiottito il protagonista del romanzo, la finezza di scrittura. Anche qui il fatto inaudito, che rovescia drasticamente la normalità, si pone nelle pagine iniziali, il resto ne è la possibile e logica conseguenza. Il passaggio dal consueto allo straordinario è, infatti, messo in scena nell’incipit nel suo transito, rapido, avvolto nel mistero, resistente ad ogni spiegazione razionale. A raccontare è un narratore fuori dalla storia, ma molto prossimo al protagonista, il professor Budai, eminente glottologo ungherese, che è partito in aereo da Budapest per recarsi a Helsinki, dove deve tenere una relazione in un congresso di linguistica. Esausto per la mancanza di riposo negli ultimi affannati giorni, durante il viaggio si addormenta pesantemente e, atterrato, si infila ancora insonnolito nel pullman. Budai conosce bene la capitale finlandese, dove ha già soggiornato varie volte, ma ora, nell’oscurità, la città gli appare estranea e inutilmente cerca con lo sguardo, attraverso il vetro di un finestrino, qualche palazzo noto o il mare. A una fermata il pullman si svuota e l’autista fa cenno anche a lui di scendere. Si ritrova sotto una tettoia, all’ingresso di un albergo, circondato da una calca, da cui fa una certa fatica a liberarsi. Un grasso usciere in pelliccia, con un berretto bordato d’oro, gli rivolge un saluto militare e spinge la porta a vetri, ma, quando il professore gli parla in finlandese, lui proprio non capisce e gli risponde in una lingua incomprensibile, indicandogli con un cenno la hall. Il dubbio già abbozzato di avere sbagliato aereo si fa certezza, ma di lì a poco Budai comprende che gli è capitato qualcosa di più bizzarro ed inspiegabile. Alla reception, infatti, scena analoga: una gran folla, una lunga coda in attesa, e, quando finalmente si trova davanti al portiere, questi non capisce il suo finlandese, ma neppure l’inglese, il francese, il tedesco, il russo con cui il professore tenta di stabilire un contatto. Con compassata professionalità registra i dati del passaporto, gli porge una chiave, prende l’assegno in dollari fra le pagine del documento, fa i conti, compila un titolo di credito in valuta locale e accompagna i suoi gesti con torrenziale e impenetrabile eloquio, ricusando il tentativo di obiettare di Budai. Intanto la folla in fila scalpita, e l’usciere indica insistentemente la cassa a quel cliente riottoso. A Budai, inghiottito da tanta estraneità, non resta che adattarsi, ligio a quei gesti prescrittivi, annegati in un profluvio di parole che gli suonano irrimediabilmente vuote e insignificanti.
Tuttavia, pur turbato, non si perde d’animo e fin dalla sera del suo arrivo, mentre soddisfa l’esigenza di mangiare qualcosa in un self-service prima di andare a letto, comincia l’esplorazione di quella strana realtà in cui è precipitato. E ad essa si dedica puntigliosamente nei giorni successivi facendo appello a tutto il suo sapere, a tutta la sua razionalità, a tutta la sua pazienza allenata dallo studio delle antiche etimologie. Ben presto si arrende all’impossibilità di trovare qualcuno con cui mettersi in contatto con una delle numerose lingue moderne che padroneggia, tantomeno gli possono essere utili quelle antiche che pur conosce. Cerca allora di affinare il suo orecchio, uso a penetrare nei segreti delle più disparate lingue del pianeta, ma "le vocali erano mormorate e di colore variabile, le consonanti rauche e biascicate, accompagnate talvolta da suoni occlusivi simili a schiocchi di lingua. Quest’ultima caratteristica ricordava i click delle lingue degli Ottentotti e dei Boscimani dell’Africa meridionale, mentre la frequenza del nesso tl l’azteco centro-americano".
Con tutto il suo bagaglio glottologico, Budai non riesce nemmeno ad essere certo del nome dell’unica persona con cui entra faticosamente in contatto: la ragazza addetta all’ascensore dell’albergo. Gli sembra di afferrare un Epepe, ma, quando lei gli ripete il suo nome, dubita: forse si tratta di Tetete, o forse di Bebebe. La pronuncia delle parole sembra, infatti, cangiante e mutevole ogni volta che queste vengono ripetute. Non ottiene migliori risultati, quando, chiuso in camera, si accanisce ad applicare consolidate metodologie per scoprire la chiave della lingua scritta, valendosi di un elenco telefonico e di giornali. Mette insieme un lungo elenco di segni inusuali e bizzarri, che vagamente gli ricordano le rune dell’antico germanico, o i tratti cuneiformi sumerici, ma non capisce neppure se si tratti di una scrittura alfabetica, o sillabica, o consonantica, o ideogrammatica, o geroglifica. Solo i numeri arabi gli appaiono familiari.
La mappa della rete metropolitana, vicino all’albergo, pur abbastanza intricata, gli permette di orientarsi e di procedere in una sistematica esplorazione della città. È una sterminata metropoli svettante di grattacieli, che pare non avere né un centro né dei confini, uniforme, piatta, continua, priva di segni distintivi. La percorrono fiumane umane, tanto formicolanti quanto intruppate, che si muovono velocemente, o che si addensano in interminabili file. La molteplicità dei caratteri somatici suggerisce una società decisamente interetnica, senza un gruppo prevalente, ma medesimi sono i comportamenti, la foggia degli abiti e delle acconciature e irrimediabilmente una sola è la lingua. Quando gli accade di fermare qualcuno, alle sue domande e ai suoi gesti sempre simile è la reazione: qualche istante di disponibilità curiosa, poi sorrisi ironici, canzonatori, beffardi, a cui fa seguito, se lui insiste, un evidente fastidio e dispetto.
Affannosamente il professore percorre ogni giorno una porzione diversa della megalopoli, ne scopre quelli che paiono essere cantieri, mercati generali, strani templi, ma non riesce mai ad individuare il luogo che gli possa essere di una qualche utilità: un’agenzia di viaggi, una compagnia aerea, un’ambasciata, per non parlare di una stazione ferroviaria o di un aeroporto. E non riesce neppure a farsi un’idea sull’ubicazione nel pianeta della dannata parte del mondo in cui è finito: non forniscono indicazioni né le condizioni meteorologiche - tempo secco, invernale come dalle sue parti in febbraio -, né i cibi - alimenti che si trovano ovunque, chissà se locali o d’importazione -; neppure la moda orienta: articoli che rispecchiano gli standard internazionali, con le consuete distinzioni di qualità fra i grandi magazzini e le boutiques. E sempre quella folla fitta, compatta, impenetrabile, che popola ogni spazio – i marciapiedi, i negozi, le tavole calde, le stazioni del metrò – in attesa in dense file per ritirare in albergo le chiavi delle stanze, per ottenere una giornata di lavoro nei cantieri o ai mercati generali, ed anche per guadagnare una panchina in un giardino pubblico. Una folla anonima, da cui non si stacca nessuna individualità. Appare, dunque, quella in cui è precipitato Budai, come una megalopoli concentrazionaria – anche se questo attributo non è mai usato nel romanzo – che tutto e tutti omologa a un implicito e autoritario principio d’ordine: proiezione, forse, di quell’inferno che si preparano a diventare le metropoli note alle nostre mappe.
Il professore, in quello che, fino alle ultime righe del romanzo, appare un inutile peregrinare, affronta questa realtà parallela ora con curiosità, ora con disgusto, ora animato dal suo spirito di ricerca, ora frustrato dalla disperazione, ora acceso da un’improvvisa aggressività, mai sperimentata prima, ora ora annichilito e umiliato dalle difficoltà e dai disagi crescenti. Deve anche affrontare la malattia e la completa mancanza di denaro, costretto a intrupparsi in una di quelle interminabili file per ottenere una giornata di lavoro da facchino e a dormire in un improvvisato riparo di lamiere. Lacero e cencioso, ridotto all’ombra di sé, ma non abbandonato dallo spirito vitale, un giorno, quando ormai non spera più in una qualche soluzione, cattura il segno di una via d’uscita possibile. Un segno fragile e debole, la labile indicazione di un percorso ancora tutto da compiere, l’incerta possibilità del nostos desiderato, ma che pur rappresenta il rovescio della megalopoli concentrazionaria, l’anello che non tiene, il buco rotto nella rete forse salvifico nel suo improvviso baluginare.
- Ci sono 0 contributi al forum. - Policy sui Forum -