Un’occasione perduta in Sicilia: la primavera di Catania

La primavera di Catania come “case study” di postdemocrazia. A proposito di: L’occasione perduta : Ricordi di un assessore della primavera di Catania / Paolino Maniscalco ; prefazione di Salvatore Resca. - Viagrande : Algra, 2023. - 336 p. - ISBN 978-88-93417-15-0.
C’è stato un momento della sua storia in cui Catania assurse agli onori della ribalta nazionale non per i suoi record negativi – come la quantità di spazzatura per le strade o in generale la cattiva amministrazione – bensì per essere stata protagonista di un tentato rinnovamento che ebbe modo di estendersi per quasi due legislature (dal 1993 a tutto il 1999), grazie anche a quel senso di liberazione dai vincoli della vecchia politica e dei tradizionali partiti che era stato l’effetto della stagione di “mani pulite”.
Siamo nella seconda metà degli anni Novanta, quando i Comuni interpretarono un grande protagonismo; tra di essi fu proprio Catania una delle città maggiormente presenti sulla scena nazionale, rivestendo la sua esperienza, con tutti i suoi errori e realizzazioni positive, utili lezioni che possono avere un valore significativo per capire le contraddizioni e i limiti che incontra la sinistra quando si tratta di gestire in concreto una realtà complessa e piena di interessi contrastanti, specie nella realtà meridionale.
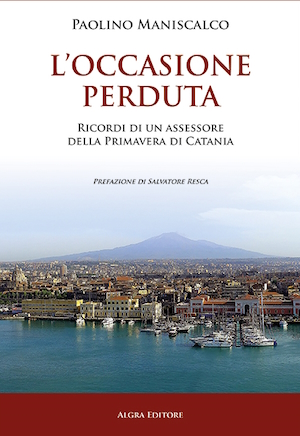
- Copertina di L’Occasione perduta, di Paolino Maniscalco
Di questa vicenda – ancora poco oggetto di studio – ci dà una testimonianza in presa diretta uno dei suoi maggiori protagonisti, Paolino Maniscalco nel suo volume L’occasione perduta. Ricordi di un assessore della primavera di Catania (Algra Editore, 2023), che ricoprì uno degli incarichi più delicati e difficili, quello di curare la Nettezza Urbana, proprio il settore nel quale Catania si era distinta in negativo battendo ogni record nazionale e forse anche internazionale. Ovviamente Maniscalco ebbe anche altre deleghe, come quella all’ambiente e alla Protezione civile, dove riuscì a ottenere la prima legge nazionale per la prevenzione del rischio sismico. Ma è nell’essere riuscito a eliminare dalle strade la “munnizza” (come si dice a Catania) e aver reso finalmente la città pulita, come hanno riconosciuto gli stessi avversari politici, il merito che maggiormente rimane nella memoria dei cittadini catanesi, visto anche il disastro che proprio in questo settore subentrò alla sua gestione.
Non ci interessa qui andare a ripercorrere le vicende di questa stagione, del resto ben ricostruite dall’autore nella prima parte del testo, dove si avvale anche degli appunti da lui tenuti nel suo Diario, quasi quotidianamente redatto; vicende importanti per capire quanto faticoso e impegnativo sia amministrare quando lo si voglia fare davvero e non si interpreti il proprio ruolo solo come un modo per “fare carriera”, in vista di ulteriori e più ambiziosi ruoli, oppure per altri meno commendevoli scopi legati alla mera gestione del potere, con i benefici (in tutti i sensi) che se ne possono trarre.
Cerchiamo invece di lumeggiare alcuni aspetti di tale vicenda che possono essere paradigmatici e servire da insegnamento a futura memoria (ammesso che se ne disponga a sufficienza). Iniziamo innanzi tutto dal simbolo di tale stagione, identificato nel sindaco Enzo Bianco, il cui travolgente successo amministrativo lo portò a diventare prima presidente dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), quindi ad essere promosso (dicembre 1999) ministro dell’Interno nel governo D’Alema, con le sue conseguenti dimissioni da primo cittadino, così segnando in modo decisivo la fine della primavera di Catania e il sopraggiungere dell’inverno con la disastrosa sindacatura dell’allora medico di Berlusconi, Umberto Scapagnini. La conseguenza fu che, nonostante le sue realizzazioni, la “primavera” non fece sbocciare fiori né tanto meno portò frutti; come ammette lo stesso Maniscalco, non si riuscì “a scardinare il sistema di potere della nostra città né a far diventare i catanesi rispettosi degli altri e delle regole […]” (p. 15). Resta la domanda se, sulle basi di quanto già fatto, sarebbe stato possibile negli anni successivi portare a compimento tale difficile compito. Ma la decisione (e l’ambizione) di Bianco portò alla sua fine: è stato questo uno dei tre più significativi errori che dall’autore vengono diagnosticati quali motivi fondamentali dell’incompiutezza dell’opera, proprio quando – dopo aver assestato la macchina amministrativa – era giunto il momento di procedere più spediti; cioè quando, “dopo sei anni mezzo di malavita eravamo al punto di svolta: adesso finalmente si poteva parlare dei luoghi dove si crea l’anima e l’identità di una città, della promozione della cultura dell’autogestione, di avviare iniziative veramente nuove per la mobilità e di tante altre cose ancora” (p. 172). Al danno di per sé delle dimissioni di Bianco, si accompagnarono le sue indecisioni circa la designazione del successore, che voleva fosse un suo uomo, dando così l’impressione di voler eterodirigerlo anche da ministro. Chi poteva avere una reale presa sulla città e specie sui quartieri periferici, il vice-sindaco Paolo Berretta, che aveva di fatto supplito Bianco troppo occupato coi suoi continui spostamenti nella qualità di presidente dell’ANCI, venne da lui boicottato: “sapevamo tutti che Bianco non gradiva le persone che avevano autonomia e avrebbero potuto, anche solo potenzialmente, fargli ombra. Dispiace aggiungere che Bianco gestì questa vicenda nel suo solito modo: senza accettare alcun confronto, limitandosi a troncare ogni canale di comunicazione. / Fu un atto masochistico da tutti i punti di vista.” (p. 273). Nonostante queste avvisaglie, tuttavia, l’ottimismo regnava e si pensava che il candidato sul quale alla fine si era trovato l’accordo (Mario Libertini, giurista e ambientalista) avrebbe potuto farcela grazie alle sue qualità intrinseche. Ma non si aveva il polso della situazione, sicché si andò incontro a una inaspettata e amara sconfitta che portò alla sciagura di Scapagnini, capace in pochi anni di sciupare quel che di buono era stato fatto, portando anche al dissesto le finanze del comune.
Un altro dei tre errori diagnosticati dall’autore, che però ha inciso maggiormente nei primi anni della Giunta, è stata la divisione del fronte progressista ad opera de La Rete (“i puri” di Leoluca Orlando), che ha messo in difficoltà la Giunta, in minoranza nel Consiglio, in nome dell’egoismo di partito, delle ambizioni personali e della regola che pare da sempre governare le forze progressiste, per le quali il principale nemico è non la destra, ma “colui che gli sta a fianco” (p. 28). In fondo, non dobbiamo il governo Meloni appunto ad un atteggiamento di questo tipo?
Ed infine, terzo decisivo errore della “primavera”: l’essere stati assorbiti così tanto dall’attività amministrativa, da dimenticare il rapporto con i cittadini, che pure era stato alla base del successo elettorale con il coinvolgimento delle associazioni (tra le quali spicca il ruolo di CittàInsieme di padre Salvatore Resca, che scrive la prefazione del volume), dal quale era nato il “patto per Catania”. A sanare questo iato che si andava formando non contribuiva certo la personalità di Bianco “fondata non sul coinvolgimento ma sul ghe pensi mi” (p. 145). La stessa CittàInsieme era passata dall’esplicito appoggio e dalle critiche solo alle singole scelte ad una progressiva delusione e distacco, specie con la seconda sindacatura (1998-1999), a cui non si poteva rimediare con le strutture di partito sempre più evanescenti, specie a sinistra, a seguito della discutibile scelta di una “organizzazione leggera”, voluta soprattutto da Veltroni.
La “ossessione del fare” ha pertanto risucchiato nel gorgo delle incombenze quotidiane e dei labirinti burocratici gli amministratori volenterosi, facendo loro dimenticare una regola che la destra ha avuto sempre ben presente: non è la correttezza amministrativa e l’anonimo interesse generale a premiare, ma la visibilità politica e l’interlocuzione, anche personale, con i singoli, la gratificazione che questi pensano di ricevere anche solo avendo prestata attenzione o udienza dal politico. Il fatto di consegnare o di firmare le lettere in cui si comunica l’accoglimento dovuto di una richiesta, non lasciandone l’incombenza a un funzionario, fa parte di quella sapienza politica posseduta dalla destra ma assente nella sinistra, votata solo all’efficienza amministrativa. E infatti, i vecchi assessori ci tenevano molto a questa prassi; e, commenta Maniscalco, “alla luce dei risultati elettorali del 2000, debbo dire che erano più saggi di me” (p. 49). In effetti, “l’unica cosa in cui non sono mai riuscito pienamente era la pubblicizzazione del mio lavoro” (p. 52); ma nella società dello spettacolo l’apparire è molto più importante dell’essere, l’annuncio più decisivo della realizzazione, non le buone pratiche e la riorganizzazione che veniva effettuata dell’attività amministrativa. Un caso tipico è quello dell’assessore al bilancio Rino Battiato, che aveva evitato il disastro finanziario e che “recuperava miliardi come fossero noccioline” (p. 128), ma il cui operato era del tutto ignoto all’opinione pubblica. Anche le iniziative elencate, ad es., nella prima relazione semestrale del sindaco, erano sì “tutte cose importanti ma poco visibili, tranne le demolizioni [delle costruzioni abusive nell’oasi del Simeto] che non creavano certo consenso” (p. 71). Infatti, “la gente si aspettava risultati visibili e immediati e noi non riuscivamo a far comprendere le difficoltà: al contrario il nostro stare a testa bassa sui problemi ci isolava anche da chi ci sosteneva […]” (p. 77). È l’insegnamento che anche io ho appreso quando ho avuto la possibilità di gestire una piccola struttura (un Dipartimento universitario): ai fini del consenso contavano molto più i rapporti personali e le piccole cortesie che le realizzazioni pur importanti in favore della struttura o dell’interesse generale o degli studenti.
E qui veniamo al punto cruciale che sta al fondo dell’occasione perduta: l’incapacità di creare consenso a fronte della riorganizzazione del centrodestra che aveva saputo, attraverso i “patronati”, diffondere sul territorio una rete di assistenza e di vicinanza al cittadino che non solo lo aiutava nello svolgimento delle pratiche, ma ne orientava il voto facendogli credere che quanto dovuto e i servizi offerti (pagati coi soldi di tutti i cittadini, cioè dagli enti che “esternalizzano” a tali patronati lo svolgimenti di pratiche burocratiche) fossero un generoso omaggio o interessamento del politico di riferimento a cui faceva capo uno o più patronati. Così le sezioni di partito e le segreterie politiche furono di fatto sostituite dai patronati, e poi anche dai CAF, mentre le forze di sinistra erano sprovviste di terminali capaci di comunicare col territorio e di intercettare le esigenze e gli umori dei cittadini, quel “sentire della gente” che ha più peso della razionalità nella riorganizzazione dei servizi, come è avvenuta quando si è cercato di ristrutturare in nome dell’efficienza le linee di trasporto urbano (pp. 124-5).
Inoltre il centrodestra favorì e seppe sfruttare a pieno il cambiamento del sistema elettorale, che passò dal voto disgiunto con due schede a quello con un’unica scheda, con l’effetto di trascinamento: il voto per i consiglieri di una lista sarebbe stato automaticamente assegnato al candidato sindaco cui essa era collegata. L’astuzia di moltiplicare le liste e quindi i candidati fece esplodere il voto di preferenza per quest’ultimi con l’effetto di convogliare i voti sul sindaco Scapagnini, come dimostra l’attenta lettura delle schede elettorali: quelle a favore della destra nella maggior parte dei casi davano solo la preferenza a un consigliere della lista, con pochi voti solo per il sindaco, mentre i voti a favore della sinistra mostravano l’andamento opposto. È questo un fenomeno tipico, almeno nel Mezzogiorno, dove il voto degli elettori di centrodestra è generalmente rivolto alla persona mentre quello degli elettori di sinistra è rivolto al partito e, solo in pochi casi, viene aggiunto un voto di preferenza.
Tale incapacità di creare consenso – se è stata amplificata dall’astuzia elettorale della destra – non giustifica però del tutto l’impossibilità della Giunta di creare un movimento d’opinione a sé favorevole, specie nel mondo imprenditoriale, degli industriali e dei commercianti. I primi, poco avvezzi alla reale concorrenza, se non a parole, “aspiravano ad avere amministratori che eseguissero le loro richieste pedissequamente” (p. 280), secondo un modello di azione che a livello globale ha portato a quella che è stata chiamata postdemocrazia: in essa “sopravvivono tutte le forme democratiche compreso, cosa molto importante, lo stato di diritto – ma l’elettorato rimane passivo, si astiene da qualsiasi fastidioso attivismo e non esprime una società civile sufficientemente vivace da creare delle controlobby che contrastino l’attività silenziosa portata avanti, nei corridoi del governo, dagli interessi economici.” (C. Crouch, Combattere la postdemocrazia, Editori Laterza, 2020, p. 48). Se questo vale a livello globale e con i grossi gruppi finanziari e bancari – portando a quel potere delle lobby che ho già descritto in un mio precedente articolo (“Dalla democrazia alla lobbycrazia”, www.aldousblog.it, 30-01-23) – ha anche i suoi riflessi più caserecci a livello locale con una classe politica al servizio degli interessi dei grossi gruppi economici operanti sul territorio, come nel caso dei famosi “quattro cavalieri dell’apocalisse mafiosa” (definizione data da Giuseppe Fava) – Graci, Costanzo, Rendo e Finocchiaro; o come avviene con i commercianti, meno rilevanti ma tuttavia fondamentali per creare consenso, perché più diffusi sul territorio. A tutti costoro dà fastidio una politica forte, che voglia avere una funzione decisiva nel regolamentare e condurre su binari di correttezza e trasparenza l’attività economica e amministrativa, cioè una politica che sia poco disponibile ad assecondare i voleri del “mercato”, che poi coincidono con quelli dei “mercatori”. Quando si sono modificate le regole di appalto per l’assegnazione della raccolta della nettezza urbana e si rese possibile una più ampia partecipazione si ebbe un subbuglio (con ricorsi e proteste); la possibilità di non concorrere più in modo “protetto” sembrava una condizione inaccettabile: “le imprese siciliane (appoggiate dalla malapolitica e pressate dalla mafia) fecero la battaglia per difendere il proprio orticello dall’ingresso di nuovi competitori” (p. 299).
La stessa opposizione si manifesta quando la Giunta cerca di introdurre la gestione pubblica delle discariche, così toccando i consolidati interessi dei proprietari delle stesse, spesso inquinati dalla mafia; e la giustificazione era, a quel tempo, sempre la solita ricetta del neoliberismo: “bisognava smetterla con l’intervento pubblico che era la malattia e non la cura, etc., la solita solfa della ‘teologia neoliberista’” (p. 295); e così “la cieca difesa degli interessi di imprese fuori mercato e dei padroni delle discariche è costata a noi siciliani vent’anni di ritardi, bollette salatissime e spazzatura per strada” (p. 297).
Peccato che proprio la sinistra si sia fatta catturare da questa teologia, contribuendo per suo conto allo smantellamento dell’intervento pubblico in nome dell’efficienza del privato, sempre e comunque, più ancora di quanto fatto dalla destra (dimentichiamo forse con quale governo sono state fatte le grandi privatizzazioni?). Una efficienza più frutto di propaganda ideologica – consolidata grazie al possesso di gran parte della cosiddetta stampa indipendente – che reale, per come dimostrano i processi di ripubblicizzazione di servizi e attività prima privatizzati in gran parte del mondo, così come documenta il fondamentale testo di S. Kishimoto e O. Petitjean (Il ritorno alla gestione pubblica dei servizi di base. Comuni e cittadini chiudono il capitolo privatizzazioni, Transnational Institute et al., Amsterdam e Parigi 2017 – ma si veda anche G. Caprio, “Servizi pubblici locali: il bluff della privatizzazione”, Volerelaluna, 6-12-22).
Ma la predilezione alla coltivazione del “proprio orticello” non è una malapianta che alligna solo tra gli imprenditori; è un male assai diffuso, che interessa anche i cittadini meno compromessi col potere e di solito onesti. Ne è spia quanto dice lo stesso Maniscalco: “Quando qualcuno che viene da fuori mi chiede come mai amministratori che hanno portato la città al disastro continuano ad essere votati gli rispondo, in modo volutamente disorientante, che vincono le elezioni proprio perché amministrano male: in una città dove non funziona nulla e non c’è più la speranza di un cambiamento, tanta gente si è rassegnata ad affidarsi a un protettore, a cercare un rapporto diretto con chi occupa la stanza dei bottoni” (p. 319). È questa la situazione che ho in un mio precedente articolo definito come la “disfunzione funzionale”, illustrandola proprio con l’ultima batosta elettorale subita dalla sinistra alle elezioni comunale di Catania del 2023. Infatti, solo nello spazio vuoto dell’inefficienza il potere politico trova lo spazio della mediazione; solo grazie alla micro-illegalità diffusa (non è necessario far ricorso alla mafia) è possibile consolidare il proprio potere attraverso il non-intervento.
Solo quando le istituzioni non funzionano, l’ente pubblico è inefficiente e la società è frammentata istituzionalmente in ambiti separati, allora tanto più è necessaria la mediazione politica, tanto più il singolo cittadino ha bisogno del “patronage” (la funzione dei “patronati” e dei CAF, per l’appunto). È questo il motivo per cui la corruzione è assai più diffusa e radicata nei paesi “in via di sviluppo”, inefficienti e privi di welfare, mentre è invece ridotta nelle democrazie avanzate in cui esiste un sistema funzionale di welfare e la macchina pubblica funziona in modo efficiente e trasparente. Il fatto che gli ospedali non funzionino, per fare un esempio banale, è perfettamente funzionale: lo è per il ceto medico, che così ha la possibilità di cercare maggiori profitti grazie all’espansione della sanità privata, lo è per il ceto paramedico, che così ha più spazi di autonomia (secondo lavoro ecc.), e lo è anche per quei cittadini che sono in grado di trovare la via per un ricovero rapido o per un trattamento migliore.
Ciascuno, insomma, nella sua nicchia professionale, territoriale o settoriale trova il modo di godere di privilegi – o per assenza di intervento o per la sua presenza – che lo convincono sulla non convenienza del cambiamento complessivo. I commercianti che si oppongono ad ogni regolamentazione del traffico non fanno che difendere il proprio orticello, il proprio piccolo privilegio e se ne infischiano della maggiore razionalità del piano di circolazione o dei vantaggi complessivi per la cittadinanza. Ai pulizieri delle scuole che “cominciavano a dire che, mentre prima avevano lavorato anche d’estate, adesso che c’era la sinistra – con la sua smania di legalità – non potevano farlo” (p. 38), poco importava la corretta gestione amministrativa e la lotta alla mafia, se per loro questo si traduceva in una minaccia alla continuità del lavoro. La lotta alla mafia, che porta al crollo dei grandi imprese dei cavalieri del lavoro, crea il malcontento dei lavoratori che si vedono ormai in mezzo alla strada: in questi casi o si è in grado di dare risposte sostitutive, senza rinviare ad un nebuloso ed incerto futuro; oppure si deve avere la forza di esercitare una egemonia tale da fornire una forte motivazione ideologica che rende tollerabile l’attesa del cambiamento ed è pronta a scontare anche una certa quantità di difficoltà iniziali, affrontando il necessario periodo di “transizione”.
In assenza di una prospettiva complessiva, di un movimento politico capace di motivare e di rendere salda la voglia del cambiamento, fornito di una impalcatura culturale e organizzativa in grado di tenere legati a sé cittadini e lavoratori, non può che trionfare quel “particulare” che – riconosce amaramente Maniscalco – la destra, con molta più furbizia, ha imparato a sfruttare; i suoi esponenti hanno “capito che è in una città che non funziona è più facile mantenere il potere e hanno focalizzato loro attività non sull’amministrazione ma su come controllare l’elettorato: questo è il focus del loro lavoro; poi nei ritagli di tempo si occupano del resto.” (p. 319).
In fondo, si domanda Maniscalco, “ma chi me lo fa fare” (p. 96), chi lo spinge a lavorare come il cavallo Godrano (p. 77) per poi ricavarne delusioni e magari qualche inchiesta giudiziaria (che sempre lo ha visto uscire indenne)? La risposta è semplice e per molti comprensibile: in fondo egli viene da una generazione in cui la politica non era un affare o un’impresa nella quale scommettere il proprio “capitale umano” per ricavarne vantaggi, come recitava una copertina di Capital del 1980 dove l’immagine a piena pagina di Claudio Martelli poneva la domanda “conviene darsi alla politica?”.
Ebbene se la domanda a cui rispondere è questa, allora certo Maniscalco ha fatto un investimento sbagliato. Se invece la politica si inserisce in un orizzonte di senso nel quale la propria esistenza acquista significato e vale la pena di essere vissuta, allora ne è valsa la pena, perché se è vero con Platone che “Una vita senza ricerca non vale la pena di essere vissuta”, è altrettanto vero che una vita senza il calore della passione politica è un grigio e oscuro affaticarsi nel quotidiano.
Sinossi editoriale
La Primavera di Catania (1993-1999) aveva avviato un virtuoso percorso di rinascita ma, alla svolta del nuovo secolo, la città piombò in quel degrado che l’opprime ancora, simboleggiato dalle strade al buio dell’amministrazione Scapagnini. Come è potuto succedere? Paolino Maniscalco, assessore in quella felice stagione, racconta gli anni dal 1993 al 2005 con un linguaggio chiaro, uno stile brioso e a tratti ironico, con una gran messe di notizie, anche inedite, frutto dei suoi diari e di una vasta documentazione. Una riflessione attenta che individua i nodi fondamentali della città, un’analisi spietata che potrebbe essere utile per ricominciare a pensare al futuro.
Paolino Maniscalco (1950) è laureato in Scienze Politiche. Dirigente della FGCI e del PCI catanese, è stato anche segretario della Camera del lavoro di Catania. Assessore per tutta la durata della Giunta Bianco, aveva le deleghe per Ambiente, Nettezza urbana, Protezione civile, Mare. Successivamente ha lavorato nel settore ambientale e ha continuato la trentennale attività per la prevenzione sismica. Oggi, da pensionato, affianca a questi interessi l’impegno civile, una (limitata) attività politica, la lettura, l’escursionismo e il giardinaggio.
- Ci sono 0 contributi al forum. - Policy sui Forum -