Socialisti e sindacato: Una pagina di microstoria leontina

Le origini del socialismo e del sindacalismo italiani sono fortemente intrecciate, come testimonia, ad esempio, il fatto che la denominazione inizialmente adottata dal partito socialista a Genova nell´agosto 1892...
Le origini del socialismo e del sindacalismo italiani sono fortemente intrecciate, come testimonia, ad esempio, il fatto che la denominazione inizialmente adottata dal partito socialista a Genova nell´agosto 1892, nel suo congresso di fondazione, fu quella di Partito dei Lavoratori Italiani [1].
***
Su fratelli, su compagne, su, venite in fitta schiera
Man mano il campo d´azione cominció a differenziarsi. Mentre il partito si batteva sul piano squisitamente politico per la conquista delle pubbliche istituzioni e la trasformazione della societá da capitalista in socialista, le associazioni di categoria e le Camere del Lavoro organizzavano i lavoratori, iscritti o non iscritti al partito, per la difesa dei loro diritti e per la conquista di migliori condizioni di vita.
La Confederazione Generale del Lavoro (CGdL), di ispirazione socialista, con iniziali 250.000 iscritti, fu fondata nel congresso nazionale tenuto a Milano dal 29 settembre al 1° ottobre 1906 [2].
In seguito si costituirono altri sindacati, come lˇUnione Sindacale Italiana (USI) [3], nata nel 1912 da una scissione della CGdL, guidata da sindacalisti-rivoluzionari e da anarco-sindacalisti, e la Confederazione Italiana Lavoratori (CIL), fondata nel 1918, di orientamento cristiano-democratico, i cui esponenti piú noti furono Achille Grandi e Giovanni Gronchi.
L´avvento del fascismo e le sue leggi fascistissime misero fine anche alle libertá sindacali e nel 1926 tutti i sindacati si trovarono nell´impossibilitá di operare.
Il 4 gennaio 1927 il vecchio gruppo dirigente riformista della CGdL [4] ne decise perció lo scioglimento.
La decisione non fu peró condivisa dal suo Segretario Generale, in carica dal dicembre 1925, il socialista Bruno Buozzi [5], che dall´ottobre 1926 si trovava in esilio a Parigi. Egli, nel febbraio 1927, ricostituí la direzione del sindacato, riuscendo ad organizzare nella risorta CGdL circa 200.000 lavoratori italiani emigrati [6]. Aderí anche alla „Concentrazione antifascista“ e pubblicó il giornale L´Operaio Italiano, introdotto clandestinamente anche in Italia.

Nel corso della seconda guerra mondiale, dopo vari incontri, organizzati soprattutto dal socialista Oreste Lizzadri [7], tra gli esponenti delle principali correnti sindacali italiane, il 9 giugno 1944 fu firmato il „Patto di Roma“ che diede vita al sindacato unitario „Confederazione Generale Italiana del Lavoro“ (CGIL).
L´importante documento fu firmato da Emilio Canevari (PSIUP) [8], Giuseppe Di Vittorio (PCI) e Achille Grandi (DC).
Nel primo congresso libero (giugno 1947) della CGIL, che allora rappresentava 5.735.000 lavoratori, fu eletto Segretario Generale Giuseppe Di Vittorio.

Successivamente l´avvento della guerra fredda e la divisione del mondo in due blocchi contrapposti, quello occidentale guidato dagli USA e quello comunista formatosi attorno all´URSS, ebbero ripercussioni anche in Italia, ponendo fine all´unitá antifascista che si era formata contro il nazifascismo.
Ne risentí in particolare il movimento socialista, in cui la convivenza nel PSIUP [9] dell´ala che privilegiava l´unitá della classe operaia (Nenni, Morandi, Basso) con quella che propendeva per un´iniziativa autonoma socialista (Saragat, Mondolfo, Faravelli) si riveló alquanto difficile, tanto che Saragat, l´11 gennaio 1947, promosse la scissione che diede vita al (nuovo) Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (PSLI, poi PSDI), mentre il PSIUP ritornó alla prestigiosa denominazione di PSI.
La scissione, detta “di Palazzo Barberini”, ed altre minori successive divisero, per molti anni, il movimento socialista italiano in due parti: il PSI di Pietro Nenni e il PSLI di Giuseppe Saragat.
Il nuovo clima politico non risparmió neanche il movimento sindacale. Nel 1948 la componente democristiana della CGIL, che giá poteva contare sulla capillare struttura organizzativa delle ACLI [10], si scisse dal sindacato unitario, per costituire la „Libera CGIL“, che il 30 aprile 1950 prenderá la denominazione di CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) [11].
Un´altra scissione fu operata il 4 giugno 1949 dalla corrente socialdemocratica e da quella repubblicana, che fondarono la Federazione Italiana dei Lavoratori (FIL) che peró il 5 febbraio 1950 cessó ogni attivitá.
Infatti, mentre i vertici della FIL confluirono nella Libera CGIL (poi CISL), la grande maggioranza della base, di area PSLI e PRI, e un forte gruppo di sindacalisti socialisti provenienti dal PSU [12], il 5 marzo 1950 diedero vita all´Unione Italiana del Lavoro (UIL), con segretario il socialista del PSU Italo Viglianesi [13].
Rimasero invece nella CGIL la corrente comunista e quella socialista, guidata da Fernando Santi (PSI).

Col passare degli anni e con la distensione e grazie alle forti aspirazioni unitarie dei lavoratori italiani, i rapporti fra i sindacati di diversa matrice politica si fecero meno tesi. In questo nuovo clima di collaborazione emersero nuovi e prestigiosi leader di area socialista, per formazione e/o militanza, in tutte le organizzazioni dei lavoratori. Ricordiamo, fra i tanti, quelli che furono alla guida delle loro organizzazioni, quali Guglielmo Epifani (CGIL), Susanna Camusso (CGIL), Ruggero Ravenna (UIL), Giorgio Benvenuto (UIL), Pietro Larizza (UIL), Luigi Angeletti (UIL), Carmelo Barbagallo (UIL), Pierre Carniti (CISL), Livio Labor (ACLI).

Il contributo piú importante dei socialisti alla lotta dei lavoratori italiani fu probabilmente l´approvazione dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300), dovuto principalmente all´impegno e alla tenacia di due grandi socialisti: Giacomo Brodolini e Gino Giugni.
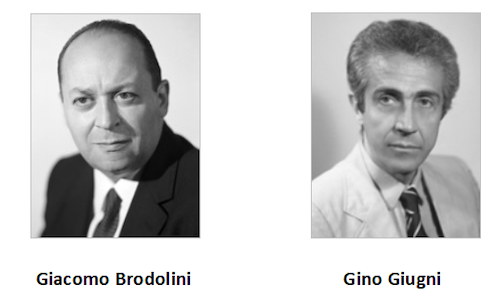
***
Vulemu u pani, vulemu u vinu... e Cicciu Marinu!
La prima forma organizzativa del proletariato lentinese fu la costituzione di un Fascio dei Lavoratori, sorto, come altrove, dall´incontro tra intellettuali progressisti e operai abbrutiti dal lavoro, dalla disoccupazione e dalla miseria. Il Fascio di Lentini sorse, sull´onda della propaganda del tribuno catanese Giuseppe De Felice Giuffrida [14], per iniziativa dell´avvocato lentinese Vincenzo Consiglio Zappulla [15], che dunque puó considerarsi il primo socialista di Lentini.
Il Fascio di Lentini, fondato il 25 dicembre 1892, si proponeva di combattere ogni forma di sfruttamento economico, ogni forma di sudditanza politica, tutti i privilegi.
Il fascio, che arriverá a contare 650 soci, si poneva anche progetti concreti, come quelli di favorire la solidarietá fra i lavoratori e il mutuo soccorso, l´assicurazione collettiva e l´istruzione, l´istituzione di una cooperativa di consumo3.
Se si considera che tali propositi erano piú o meno comuni ai molti altri Fasci dei Lavoratori, organizzazioni politico-sindacali sparse in tutta la Sicilia [16], si capisce bene come la nobiltá terriera semifeudale e parassitaria dell´isola e la grossa borghesia che ne scimmiottava lo stile di vita fossero estremamente impaurite da questi propositi ed invocassero l´intervento dello Stato, da esse controllato grazie al suffragio ristretto.
La reazione del governo di Francesco Crispi non si fece attendere: il 3 gennaio 1894 venne pubblicato il decreto di stato d´assedio, il generale Morra di Lariano venne inviato in Sicilia al comando di 40.000 uomini, ai due deputati socialisti inviati dal PSLI, Gregorio Agnini e Camillo Prampolini, venne impedito persino di sbarcare.
La repressione dei Fasci, sciolti e dispersi, si concluse col tragico bilancio di un centinaio di morti e di circa 2.000 arresti, compreso quello di De Felice, nonostante egli godesse dell´immunitá parlamentare.
A Lentini l´avv. Consiglio se la cavó con la destituzione da ufficiale di complemento.
Sará agli inizi del nuovo secolo che potrá aversi una ripresa dell´attivitá politico-sindacale dei socialisti a Lentini, grazie allo stesso Consiglio e ad altri due avvocati: Francesco Sgalambro, fondatore di una “Lega Contadini di Lentini” e Raimondo Bruno, che nel 1916 sará eletto sindaco della cittá. Nonostante i suoi indiscussi meriti amministrativi e sindacali, questo gruppo dirigente socialriformista, spostatosi su posizione interventiste e nazional-patriottiche fin da prima della guerra 1915-18, alla fine del conflitto fu costretto a cedere la guida del movimento operaio, esasperato ed affamato dalla guerra [17], a nuovi dirigenti aderenti al PSI ormai approdato in posizioni rivoluzionarie e affascinato dalla Rivoluzione bolscevica.
A mettersi in luce fu principalmente Filadelfo Castro [18], pittore di carretti, fortemente sostenuto da Maria Giudice, una carismatica attivista inviata in Sicilia dalla Direzione del PSI [19].
L´intensa attivitá politico-sindacale di Castro fu volta a favore soprattutto del bracciantato locale e allo sviluppo del PSI, che nel 1920 conquistó l´Amministrazione Comunale; ma l´azione dell´ intraprendente dirigente fu interrotta dall´avvento del fascismo [20].
La Lentini del secondo dopoguerra, in cui gran parte della popolazione, intristita dai lutti e dalla miseria, era costretta a misurarsi giornalmente col problema della fame e della disoccupazione, dovette registrare anche il continuo afflusso di ex combattenti, di ex partigiani [21], di ex prigionieri di guerra, di mutilati e invalidi.
I primi partiti a riorganizzarsi furono quello socialista, ancora guidato da Filadelfo (Delfo) Castro, che si insedió di nuovo nei locali di via Italia, costruiti dai lavoratori da prima del fascismo e che aveva il suo zoccolo duro negli assegnatari del feudo Bonvicino e nei carrettieri [22] e quello comunista, guidato dal noto cooperatore Francesco (Ciccio) Marino, ragioniere-geometra, il quale rappresentava essenzialmente il bracciantato povero a giornata, assetato di terra [23].
Le forti personalitá dei due popolari leader [24] finirono per confliggere e i movimenti da loro diretti presero a rivaleggiare, nonostante nazionalmente fossero legati da una Patto di unitá d´azione.
Il PCI di Lentini nel 1944 si allocó in un locale in affitto di via Roma n. 10. Nella stessa casa, sia pure per un breve periodo, a partire dal 1° giugno 1944, trovó sede anche il sindacato unitario CGIL, guidato dallo stesso Francesco Marino, osannato dal bracciantato senza terra. Il che dimostrava i troppo stretti legami fra PCI e sindacato, che a Lentini si prolungheranno per diversi anni.
Comunque, dopo poco tempo, la massa dei lavoratori occupó i locali dell´ex Dopolavoro fascista [25], appartenenti al Comune, che da allora rimasero sempre sede del sindacato CGIL.
Come piú sopra ricordato, l´11 gennaio 1947 ebbe luogo la scissione socialdemocratica, guidata da Giuseppe Saragat, che diede vita al PSLI, poi PSDI.
Filadelfo Castro, giá in rotta coi comunisti e con la sinistra del PSI, aderí alla scissione socialdemocratica, trascinando nell´impresa l´intero gruppo consiliare e la quasi totalitá della base, mentre il PSI, cui rimasero fedeli pochissimi aderenti [26], praticamente scomparve dalla scena politica.
Stretto fra una socialdemocrazia orbitante intorno all´Amministrazione Comunale e alla sua cooperativa di “bonvicinoti” e un PCI ormai dotato di un giovane e attivo gruppo dirigente, tutto proteso alla conquista della guida della classe operaia, non ci fu piú spazio per il PSI, assente anche organizzativamente in cittá. Ovviamente anche la sua presenza nel sindacato ne risentirá.
Di conseguenza il sindacato CGIL divenne di fatto, e per molti anni, monopolio comunista, anche grazie al lavoro di ottimi dirigenti [27].

Tuttavia una presenza socialista in cittá ci fu certamente in due casi.
Almeno fino al 1946 lavoró nel sindacato il giovanissimo, ancora minorenne, Sebastiano Centamore, la cui moglie Elena Nipitella, eletta nel 1946 come indipendente nella lista del PCI, sará la prima donna in assoluto a sedere nel consesso civico di Lentini [28].
Un altro caso di presenza socialista nel sindacato, davvero incancellabile – nel senso letterale della parola! - fu quella del pittore socialista Peppino Aliano [29]. Fu lui infatti a dipingere la scritta, mai piú ritoccata, dunque rimasta come ancor oggi la si vede, che sovrasta l´ingresso del sindacato, in via Conte Alaimo: Camera del Lavoro [30].
Mentre la socialdemocrazia di Castro, ormai stabilmente inserita nell´area centrista governativa, iniziava la sua marcia verso un inesorabile declino, bisognerá aspettare la metá degli anni ´50 del secolo scorso per riavere a Lentini una buona presenza organizzata del PSI, non piú partito di massa, ma molto spesso determinante nello scenario politico della cittá.
Pochi sanno o ricordano che a questo periodo risale il rientro dell´on. Francesco Marino, primo segretario della Camera del Lavoro di Lentini, anche se ormai lontano dalla politica, nel PSI, a cui aveva aderito, ancora diciottenne, nel lontano 1911.
Una presenza socialista di rilievo nel sindacato sará quella di Peppino Battiato. Battiato, dipendente comunale, uno dei rifondatori della sezione del PSI e membro della sua dirigenza, si era impegnato nella CGIL, diventando segretario del locale sindacato degli EE.LL (enti locali), componente del Direttivo della Camera del Lavoro di Lentini e del Comitato Regionale EE.LL della CGIL. Affettuosamente legato ai giovani della sezione socialista, egli fu candidato del PSI, nel collegio di Siracusa, alle elezioni regionali del 7 giugno 1959, quelle in cui fu eletto per la prima volta l´on. Salvatore Corallo.
Per comprendere il carattere e la grinta di questo appassionato sindacalista, mi sembra opportuno raccontare il seguente aneddoto, al quale ebbi casualmente la ventura di assistere.
Si trattava di un serrato confronto sindacale tra il sindaco del tempo (l´on. Otello Marilli del PCI), dunque in quel momento il “datore di lavoro”, e Peppino Battiato, in rappresentanza dei dipendenti comunali, molti dei quali erano iscritti alla CGIL.
Non ricordo l´oggetto del contendere, ma solo che le istanze perorate da Battiato non erano state soddisfatte. Per cui, alla fine del concitato colloquio il sindacalista, con atteggiamento quasi ieratico, lanció la sua profezia: “Verrá giorno, quando andró in pensione, in cui saró io a sedere su quella tua sedia e a soddisfare le richieste dei lavoratori comunali!” [31].
Al che l´arguto toscanaccio prontamente rispose: “In quel giorno io diventeró un sindacalista battagliero come te e non ti daró mai tregua”.
Un´altra presenza socialista nel sindacato sará quella di Carlo Cocilovo, membro della dirigenza giovanile socialista di Lentini. Egli costituí e diresse, nel 1959-60, nell´ambito della Camera del Lavoro, il sindacato dei banconisti e lavoratori dei bar, categoria mai prima organizzata.

Dirigente sindacale certamente piu conosciuto sará Nello Imprima, originario di Scordia, ma lentinese di adozione. Militante di lungo corso nel PSI, egli, operaio, si dedicó con grande impegno alla causa del lavoro e militó a lungo nella FIOM-CGIL (metalmeccanici).
Andato in pensione, Imprima diventó segretario zonale dello SPI-CGIL (pensionati) e segretario aggiunto della Camera del Lavoro di Lentini, stimato dai lavoratori per la sua grande capacitá di ascolto e per il suo impegno nel lavoro sindacale.

Di estrazione socialista fu anche la nobile figura di Nello Saccuzzo. Giá segretario provinciale della FILLEA-CGIL (edili), divenne poi segretario della Camera del Lavoro di Lentini, amato dai lavoratori per il suo costante impegno a tutto campo: dall´elaborazione delle strategie del piú grande sindacato locale al disbrigo di una semplice pratica del singolo lavoratore.
L´accentuarsi dell´autonomia socialista portó alla presenza di socialisti anche nelle file delle altre confederazioni sindacali UIL (in cui i socialisti divennero maggioritari) e CISL.
A Lentini ricopersero importanti ruoli nella UIL due giovani sindacalisti provenienti dalle file del PSI.
Alfio Ira, che dal 1982 al 1985 divenne responsabile della UIL di Lentini e successivamente segretario provinciale della UISBA (braccianti), nonché membro della segreteria provinciale della UIL dal 1985 al 1991, anno in cui lasció l´attivitá sindacale, rimanendo peró sempre vicino ai lavoratori.
A succedergli nella direzione della UIL di Lentini sará a lungo l´ottimo sindacalista Giovanni Cannone [32], che diventerá anche componente della segreteria provinciale dell´UILA (agroalimentari), nonché del Direttivo confederale della UIL, dove rimarrá fino al pensionamento.
Dissoltisi i partiti di riferimento, per lungo tempo non emergeranno a Lentini altre figure di formazione socialista impegnate nel sindacato.

Solo di recente, a seguito delle votazioni del 14-15-16 aprile 2025, è da segnalare l´elezione del socialista dott. Giovanni Leonzio, candidato nella lista della FP-CGIL (funzione pubblica), da tempo non rappresentata nell´importante consesso, nella RSU dell´Ospedale “Garibaldi” di Catania [33].
L´importante affermazione del candidato lentinese [34] potrebbe essere il preludio di una nuova fioritura di esponenti sindacali lentinesi, e in particolare di quelli di area socialista.
Staremo a vedere.
[1] Nel successivo congresso tenuto a Reggio Emilia dall´8 al 10 settembre 1893 esso assunse il nome di Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (PSLI) e in quello clandestino di Parma del 13 gennaio 1895 quello definitivo di Partito Socialista Italiano.
[2] Non mancarono donne impegnate nella lotta sindacale come Maria Goia (1878-1924) che fu segretaria (la prima in Italia) della CdL di Suzzara e poi di quella di Cervia e Argentina Altobelli (1866-1942), segretaria nazionale della Federterra.
[3] L´USI nel 1914 si spaccherá tra la maggioranza neutralista, guidata dall´anarchico Armando Borghi e la minoranza interventista, con leader Alceste De Ambris e Filippo Corridoni, che nel 1918 fonderanno la UIL.
[4] Ne erano i leader Rinaldo Rigola (1868-1954) e Ludovico D´Aragona (1976-1961).
[5] Bruno Buozzi (1881-1944), operaio metallurgico, nel 1905 aderí al PSI e poi alla FIOM, di cui nel 1911 divenne segretario generale. Deputato socialista dal 1919 al 1926, nel dicembre 1925 divenne segretario generale della CGdL. Nel 1926 il pericolo fascista lo costrinse a riparare in esilio a Parigi, dove riorganizzó il sindacato. Ritornato in Italia, aderí alla Resistenza. Catturato dai nazisti, fu da loro assassinato, assieme ad altri militanti socialisti e antifascisti, il 4 giugno 1944.
[6] Neanche la corrente comunista accettó lo scioglimento della CGdl e nello stesso mese di febbraio 1927 a Milano decise di ricostituirla clandestinamente. L´incontro del 15 marzo 1936 a Parigi fra il socialista Buozzi e il comunista Di Vittorio e la firma della piattaforma d´azione della CGdL unica misero termine alla rivalitá tra le due organizzazioni.
[7] Sulla figura di Lizzadri si puó vedere il saggio di Ferdinando Leonzio pubblicato dalla rivista mensile online La Rivoluzione Democratica del gennaio 2025.
[8] Buozzi era stato assassinato dai nazisti pochi giorni prima e Lizzadri era impegnato a riorganizzare il partito socialista nel Meridione.
[9] Tale denominazione era stata assunta dal PSI nell´agosto 1943, in seguito alla fusione col Movimento di Unitá Proletaria (MUP) e con Unitá Proletaria (UP).
[10] Le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) furono fondate il 28-8-1944 con fine la promozione sociale e la formazione dei lavoratori cattolici secondo i principi sociali della Chiesa. Fondatore e primo presidente ne fu Achille Grande, poi sostituito da Ferdinando Storchi.
[11] Primo Segretario Generale ne fu Giulio Pastore (DC).
[12] Il PSU, fondato nel 1949, raggruppava socialisti autonomisti provenienti dal PSI e socialdemocratici di sinistra provenienti dal PSLI. Figure di spicco ne erano Romita, Mondolfo, Codignola, Viglianesi, ecc.
[13] Nel 1951 il PSLI di Giuseppe Saragat e il PSU di Giuseppe Romita si unificheranno nel Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI); di conseguenza si unificarono nella UIL anche i sindacalisti provenienti dalle due formazioni.
[14] Giuseppe De Felice Giuffrida (1859-1920) fu inizialmente un socialista indipendente; militó poi nel PSI, da cui si staccó per aderire al movimento socialriformista di Leonida Bissolati. De Felice fu deputato dal 1892 per otto legislature, sindaco di Catania e Presidente del Consiglio Provinciale di Catania dal 1914 alla morte.
[15] Consiglio Zappulla, consigliere comunale eletto nel 1891, ne era il Presidente.
[16] I Fasci erano in tutto 175, coordinati da un Comitato Centrale.
[17] Lentini ebbe, nella guerra 1915-18, 213 morti, 214 mutilati e 55 invalidi.
[18] Su Filadelfo Castro si veda il volume di Ferdinando Leonzio Delfo Castro, il socialdemocratico, ZeroBook, 2020.
[19] Su Maria Giudice si vedano: Una maestra tra i socialisti/ L´itinerario politico di Maria Giudice, a cura di V. Poma, Cariplo-Laterza, 1991; Iole Calapso, Una donna intransigente: Vita di Maria Giudice, ed. Sellerio, 1996; Maria Rosa Cutrufelli, Maria Giudice: la leonessa del socialismo, Perrone Ed., 2022.
[20] L´Amministrazione Comunale socialista fu sciolta dal regime fascista il 12-11-1922.
[21] Secondo un recente studio dell´ANPI di Lentini, presieduta dall´ex sindaco Elio Magnano, i lentinesi che parteciparono alla Resistenza armata contro il nazifascismo furono 44.
[22] Il partito socialista (PSIUP), alle elezioni del 17-3-1945 riconquistó il Comune, che gli era stato strappato dai fascisti 24 anni prima, conquistando 18 seggi sui 30 del Consiglio Comunale
[23] Marino nel 1943 fonderá la cooperativa Unione, che raggiungerá 3.000 soci.
[24] Castro nel 1946 tornó alla guida dell´Amministrazione Comunale. Marino alle prime elezioni regionali siciliane del 20-4-1947 fu eletto deputato all´ARS.
[25] L´Opera Nazionale del Dopolavoro era stata istituita dal regime fascista nel 1925 allo scopo di organizzare il tempo libero dei lavoratori.
[26] Peppino Aliano, ´Nzulu Garrasi, Puddu Saccá, Pippo Di Mauro, Andrea Magnano, Sandro Tornello.
[27] Dopo gli „anziani“ dell´immediato dopoguerra Cirino Speranza e Giulio Brunno, ricordiamo Mario Strano, il mitico protagonista dei „Fatti della Vaddara“, Fortunato Mastrogiacomo, Ciccio Ciciulla, Cirino Garrasi jr, Graziella Vistré.
[28] Centamore nel 1955-56 sará uno dei rifondatori della sezione del PSI, assieme a Delfo Pupillo, Peppino Battiato, Turi Mangiameli, Peppino Aliano, Guglielmo Moncada, Gaetano Zarbano. Centamore in seguito diventerá sindaco di Lentini (4-8-1975/17-10-1976).
[29] Peppino Aliano, nobile figura di antifascista socialista, sará il primo segretario della sezione socialista di Lentini ricostituita nel 1955-56.
[30] Chi scrive, ancora bambino nel 1944-45, ebbe occasione di assistere ai lavori. Aliano lavorava su una scala appoggiata al muro e i suoi aiutanti da sotto gli porgevano gli attrezzi.
[31] La profezia di Peppino Battiato non si avveró ed egli non divenne sindaco di Lentini. Potremmo dire peró che essa saltó una generazione, poiche sará suo figlio Davide Battiato (DC) a diventare sindaco nel periodo 1°-8-1989/24-6-1990.
[32] Cannone é omonimo, ma non parente dell´ex sindaco di Lentini, il giornalista Gianni Cannone (DC).
[33] Le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) sono consessi presenti nelle aziende con piú di 15 dipendenti. Esse sono titolari dei diritti sindacali inerenti la gestione dei permessi sindacali, delle assemblee dei lavoratori, delle affissioni, dei rapporti con la controparte aziendale. Sono anche titolari della contrattazione aziendale, con il concorso dei sindacati di categoria. I membri delle RSU sono considerati, a tutti gli effetti, dirigenti sindacali.
[34] Giovanni Leonzio é risultato il primo degli eletti dei 3 ottenuti dalla CGIL (su 27). Gli altri due sono stati Alfio Agatino Raciti e Carmelo Puglisi.
- Ci sono 0 contributi al forum. - Policy sui Forum -